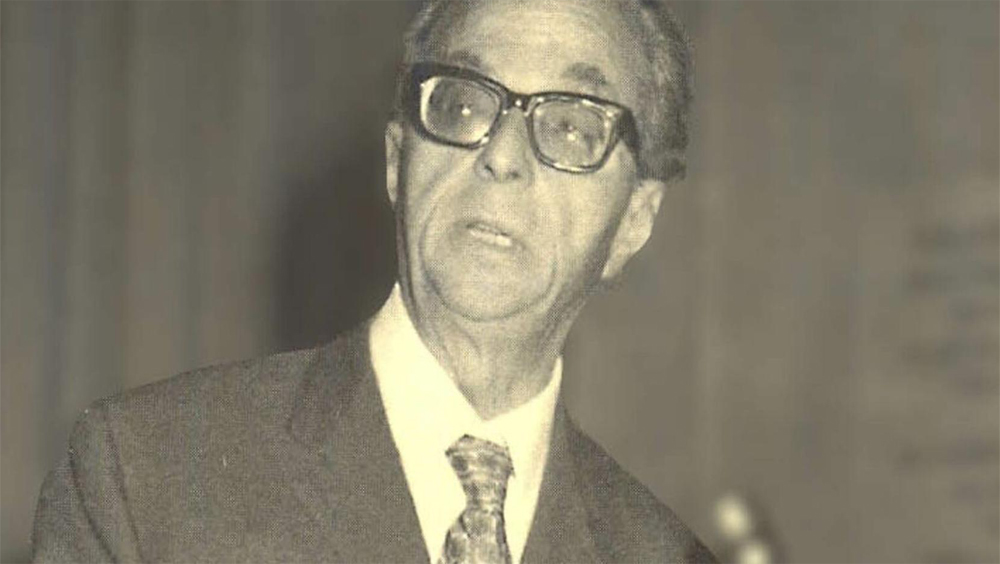Nel 1881 il tiranno colpito fu Alessandro II, figlio del tiranno suo padre, il terribile zar Nicola. Aveva cominciato il regno ascoltando i ministri riformatori che intendevano alleggerire il giogo dei servi della gleba ma la riforma adottata fu del tutto insufficiente e l’insoddisfazione dei contadini si inasprì. Allora Alessandro cambiò tattica e colpì duro quei servi che invece di baciargli la mano continuavano a protestare: si moltiplicarono i processi a interi gruppi di cittadini e pesanti furono le condanne: bastava essere scoperti con un volantino socialista per incorrere nella condanna a dieci d’anni di lavori forzati in Siberia. Il territorio russo diviso in tanti distretti fu affidato a governatori che avevano potere di vita e di morte. La protesta quindi crebbe in maniera proporzionale, l’attività dei socialisti, degli anarchici e di altri gruppi politici si fece sempre più decisa, gli attentati contro lo zar si moltiplicarono: cinque in 14 anni, particolarmente distruttivo l’ultimo (17 aprile 1880) perpetrato con la dinamite che fece undici vittime tra i militari e ferì gravemente altri soldati e vari inservienti ma non colpì lo zar. Tutti gli attentatori, scoperti, furono mandati alla forca tuttavia lo zar non riuscì più a vivere tranquillo; si racconta che sparò anche al proprio attendente che aveva compiuto un movimento imprevisto e improvviso. Alessandro ora vive nel terrore: sempre chiuso nel palazzo accerchiato da innumerevoli guardie armate e quando esce la carrozza è chiusa, la gente è tenuta lontana, cosacchi e circassi caracollano attorno alla vettura. La vendita di dinamite è severamente proibita e tuttavia e i congiurati riescono a procurasela e a tenerla pronta in due diversi passaggi che lo zar è solito percorrere. Il 13 marzo 1881 lo zar va ad una gara al maneggio, al ritorno passa a salutare la cugina Caterina e poi via al trotto per tornare a castello. La prima esplosione uccide un militare e un ragazzo che camminava lungo la carreggiata, lo zar resta ferito ad una gamba e insiste per scendere dalla carrozza e osservare di persona. Nella confusione si avvicina un secondo kamikaze che non manca l’obiettivo. Vengono arrestate e processate sei persone (due sono donne). “Quando la civiltà non ha altre risorse – dicono ai giudici – la libertà si cerca nello scoppio della dinamite che se la ride dei formidabili baluardi, che rende inutile la folla degli sbirri, che compie implacabile la sentenza della giustizia popolare, schiudendo il varco alla speranza, al coraggio, alla rivoluzione sociale”. Cinque condanne a morte, una congiurata ai lavori forzati.
L’anarchico italiano a Lione Si chiamava Sante Caserio era un contadino della pianura milanese il cui padre brutalizzato dagli austriaci era diventato pazzo lasciando nella miseria la moglie e sei figli. Sante era andato a Milano a lavorare al forno delle Tre Marie, in città aveva conosciuto gli anarchici ed era diventato un attivista. Fu arrestato e condannato, espatriò clandestinamente in Svizzera, a Lugano entrò nel circolo anarchico di Pietro Gori sognando l’utopia dell’uguaglianza sociale. Lì seppe dell’esecuzione dell’anarchico Vaillant che nel dicembre 1893 aveva gettato una bomba dentro il Parlamento di Parigi per protestare contro la politica repressiva del governo Perier. Vari deputati erano rimasti feriti, l’attentatore subito arrestato fu condannato alla ghigliottina, il Presidente della Repubblica francese Sadi Carnot aveva negato la grazia. Caserio decise di vendicare Vaillant e di punire Carnot. Il 24 giugno dell’anno successivo il presidente è a Lione per inaugurare l’Esposizione universale; alle nove di sera esce dal palazzo del commercio per andare a teatro, fa caldo, rifiuta di indossare il corpetto di metallo che porta di solito in pubblico, d’altra parte i lionesi erano così cordiali, nessuno sospetta un atto di violenza. Invece il panettiere milanese è già lì che l’aspetta con un lungo pugnale nascosto dentro un rotolo di carta. La carrozza procede lentamente, non è difficile per Caserio saltare sul predellino e vibrare il colpo gridando: Viva l’anarchia! Pochi s’accorgono di quanto succede: è abbastanza buio, c’è la confusione della festa, scoppiano i mortaretti. La ferita è profonda ed interessa vari visceri, la carrozza viene fatta ripartire di corsa, si chiama l’arcivescovo per l’estrema unzione, il telegrafo comunica la notizia a Parigi, la moglie e i figli arriveranno che il presidente è già morto. I giornali del mattino titolano “Un anarchico italiano ha ucciso il nostro Presidente” e scoppia l’ira dei francesi. Negozi e fabbriche di italiani assaltati, alcuni caffè parigini gestiti da italiani saccheggiati, un circo equestre dal nome italiano deve levare subito il tendone, alcune fabbriche licenziano gli operai emigrati dall’Italia. In Francia e altrove si osserva con interesse quanto scompiglio sia in grado di provocare anche un solo anarchico. Gli arresti si moltiplicano, in Svizzera viene fatta sgombrare la centrale degli anarchici italiani. Il processo all’attentatore dura due giorni: ancora prima del dibattito il presidente dell’assise invita i giurati a condannare l’italiano Caserio. Interrogato, l’imputato non risponde; dice di essere un semplice panettiere, non una spia. Rifiuta il suggerimento del difensore di affermare che suo padre non era sano di mente. Viene letto un suo memoriale che parla di contadini che muoiono di fame e di pellagra e di ricchi che vivono nell’ozio, accusa la società del suo tempo. Il presidente del tribunale ordina che lo scritto venga distrutto. Il 3 agosto la condanna a morte. Sante grida: “Viva la rivoluzione sociale! Coraggio compagni, viva l’anarchia!” Viene eretta una ghigliottina e il 15 agosto l’italiano
viene fatto salire sul palco dell’esecuzione: mentre lo inginocchiano davanti ceppo grida di nuovo “Coraggio compagni, viva l’anarchia!”
L’ignara Sissi Il 10 settembre 1898 la vittima è Elisabetta di Wittelsbach, imperatrice d’Austria, la bella Sissi. È in vacanza a Ginevra con qualche amica e poca servitù; all’una e mezzo del pomeriggio, con una dama di compagnia sta andando verso l’imbarcadero quando sbuca un uomo armato di coltello che la colpisce al petto. Cade ma si rialza, dice che non è niente, che bisogna affrettarsi perché il battello sta per partire ma appena salita a bordo crolla. Sono i cocchieri fermi al posteggio che bloccano l’attentatore, è un italiano. Il giorno dopo il Corriere della Sera scriverà: “Tutti i rivoluzionari della peggior specie continuano a trovare nella Svizzera il loro miglior rifugio e là stampano i loro giornali incendiari e vi combinano i loro ritrovi. Fu appunto a Ginevra, ora profondamente indignata e commossa, che nel 1882 fu permessa liberamente una conferenza di anarchici, che poi si sciolse al grido: “Abbasso Dio, abbasso la patria, i governi, i borghesi. Nemico nostro è tutto ciò che regna”. L’attentatore di Sissi, Luigi Lucheni, è italiano di Parma ma nato a Parigi, è anarchico. Confessa che non aveva un motivo personale o patriottico per assassinare l’imperatrice; era esasperato per la sua amara sorte e motivato ideologicamente. Figlio di una ragazza madre, una bracciante emiliana che era andata a partorirlo a Parigi e lì l’aveva abbandonato. Il bambino crebbe dunque solo, in un orfanotrofio, divenne necessariamente un ribelle e un vagabondo. Lavorò come manovale in Italia e in Svizzera covando un astio verso quanti erano più fortunati di lui e maturando un irrefrenabile desiderio di vendicarsi su qualcuno delle caste superiori che considerava responsabili della vita grama dei poveri. Nel settembre 1837 lavorava a Ginevra; seppe da un cocchiere dell’arrivo dell’imperatrice d’Austria che viaggiava in incognito, sempre vestita di nero (aveva perso tragicamente due figli e una sorella) e per caso la incrociò mentre correva verso l’imbarcadero. Estrasse un coltellaccio (o una lunga lima) e la colpì con un solo fendente al cuore. Subito arrestato, il Lucheni a chi lo interrogava rispose d’aver colpito l’imperatrice: “perché sono anarchico, perché sono povero, perché amo gli operai e voglio uccidere chi è ricco”. Aggiunse che avrebbe preferito compiere un attentato a Lucerna perché in quel Cantone era in vigore la pena di morte. Quale profitto s’aspettava dal suo gesto? “Colpire i perseguitori degli operai”, rispose. Potendo tornare indietro rifarebbe quel gesto? “Lo rifarei”, concluse. Venti minuti di camera di consiglio poi la sentenza: ergastolo. “Viva l’anarchia, morte alla società borghese! grida il condannato.
Di nuovo Umberto I Gli ultimi anni del 1800 furono assai travagliati per il nostro Paese: condizioni economiche difficili, alto tasso di senza lavoro, situazione degli operai e dei contadini pessime. Nel giugno 1894 fu il presidente del Consiglio Francesco Crispi a subire l’assalto di un anarchico, Paolo Lega, che però sbagliò bersaglio e rafforzò il potere dell’allora primo ministro. Re Umberto aveva ormai perso l’aureola di “re buono” e la moglie Margherita aveva contribuito al declino coi suoi sentimenti antidemocratici, autoritari e imperialisti che non cercava neppure di nascondere (più avanti caldeggerà l’ascesa dell’uomo forte Mussolini). Il proletariato ribolle: rivolta operaia e contadina in Sicilia, attentati dinamitardi, insurrezione armata in Lunigiana, colpi di pistola contro Crispi, lo stillicidio della guerra d’Africa. L’esasperazione è al culmine. Il 22 aprile 1897 grande festa al Quirinale per l’anniversario delle nozze del re poi tutti in carrozza all’ippodromo delle Capannelle. Poco dopo Porta San Giovanni dalla folla sbuca un tizio col pugnale pronto, riesce a salire sul predellino e ad aggrapparsi alla carrozza ma il re è lesto a scansarsi (solo uno spacco sul sedile) e l’attentatore è subito catturato.
È un velletrano che gestiva una bottega di ferramenta, si chiama Pietro Acciarito; gli affari vanno male, costretto a vendere l’attività, non trova un altro lavoro. Il pugnale se l’è costruito da sé, sull’impugnatura è incisa una A. Al processo gli chiedono il perché dell’attentato; risponde: Si buttano milioni in Africa e qui c’è la fame. Non ricordate quanto è successo in Sicilia? Il processo dura un giorno e mezzo, il tempo per decidere l’ergastolo è di soli tre minuti. Al termine Acciarito dichiara: “Oggi a me, domani al governo borghese. Viva la rivoluzione! Viva l’anarchia!”. Passano pochi mesi e la rivolta si riaccende: stato d’assedio a Roma, Firenze in mano ai cittadini per un giorno intero, disordini nelle Marche e in Romagna, in Campania, in Puglia, in Sicilia; migliaia gli arrestati, i deputati socialisti asserragliati a Montecitorio per evita re il carcere. E Umberto gioca a fare il duro appoggiandosi ai generali che approvano il governo forte. Il 6 maggio arriva la notizia che le forze dell’ordine a Pavia hanno sparato ad uno studente socialista. Scoppia lo sciopero generale, gli imprenditori rispondono con la serrata. Corrono voci incontrollabili del ritorno di parecchi emigrati, di studenti che convergono su Milano, tutti scendono in piazza. Il responsabile dell’ordine pubblico, generale Bava Beccaris proclama lo stato d’assedio, i militari possono sparare a vista, arrivano persino a catturare i frati che distribuiscono la minestra ai senzatetto. Due giorni di scontri poi il generale telegrafa al re: rivoluzione stroncata, solo due perdite tra le forze dell’ordine. Il re lo promuove e gli concede un’onorificenza. Ma tra la gente si contano 80 morti e 450 feriti. “Che illuminati governanti!” gridano al circolo anarchico di Paterson (New Jersey) giurando di farli rinsavire. Il circolo è guidato da un ex giornalista dell’Avanti! uscito dal partito su posizioni estremistiche ed anarchiche ed emigrato oltreoceano. L’attentatore è estratto a sorte: Gaetano Bresci, ex operaio dei dintorni di Prato. Un bravo stampatore su seta, un membro del circolo anarchico di questa città che ha conosciuto il carcere (un anno al confino per aver offeso una guardia municipale), che il padrone non vuole riassumere, che la crisi costringe all’espatrio. Ad aprile del 1900 la Francia offriva uno sconto a chi acquistava un biglietto per visitare la l’Esposizione universale, Bresci ne approfitta, poi parte per Genova, va a Prato a trovare gli ex compagni poi a Milano perché il re Umberto si è spostato a Monza per le ferie estive. La sera del 29 luglio va al campo sportivo dove il re assiste ad un saggio ginnico e premia i vincitori. La società organizzatrice si chiama “Forti e Liberi” (!). Il Bresci è in tribuna e quando il re lascia il suo palco e sale in carrozza gli si avvicina e spara tre colpi di pistola che vanno a segno. La fine di Umberto è immediata. I poliziotti saltano addosso all’attentatore e lo sottraggono al linciaggio. A chi gli grida assassino! risponde: “Non ho ucciso Umberto, ho ucciso un re!” Parte un’inchiesta, vengono inquisiti parenti ed amici, si cercano i membri del complotto. Il processo si tiene a Milano il 30 agosto, l’avvocato difensore di Bresci è Saverio Merlino, simpatizzante socialista, indicato da Turati. Merlino chiede un rinvio per alcune manifeste irregolarità processuali, rinvio respinto. Il difensore parla delle condizioni dei lavoratori, delle posizioni dei socialisti, dell’impossibilità di manifestare pacificamente le proprie idee ma viene ripetutamente azzittito. Il presidente fa mettere a verbale che “l’avvocato Merlino tenta di giustificare le teorie del regicidio”. Merlino ribatte come “l’ambiente e la situazione possano determinare cause di indole generale delle quali bisogna tener conto nella valutazione del delitto medesimo”. Quando gli danno la parola Bresci dichiara di essere l’unico ideatore ed esecutore dell’attentato, di non aver complici. “L’idea mi venne vedendo tante miserie e tanti perseguitati. Bisogna essere all’estero per vedere come sono considerati gli italiani, vengono chiamati persino maiali”. Conclude: “La mia condanna mi lascia indifferente, sono convinto di non essermi ingannato. Mi appello alla prossima rivoluzione”. La Corte prese le sue decisioni in nove minuti: ergastolo, di cui sette anni di segregazione cellulare continua, perdita di ogni diritto e confisca di ogni bene. Bresci morì nel carcere di Santo Stefano a Ventotene in circostanze oscure dopo appena quattro mesi. Il suo corpo e le sue cose sparirono, i documenti che riguardavano il suo processo andarono persi, la pistola con cui sparò è invece in mostra al museo criminologico di Roma. La sua famiglia e la sua città furono umiliate in malo modo ma Prato si rifece intitolandogli una strada e Carrara – capitale morale degli anarchici – nel 1986 gli eresse una grossa stele, nonostante l’opposizione del ministro dell’interno Scalfaro, perché l’uccisione di Umberto “non fu un atto terroristico ma simbolico”. Nel febbraio 1908 le vittime furono Carlo I re del Portogallo e suo figlio; gli attentatori subito inseguiti furono uccisi durante lo scontro a fuoco con la polizia. Nel marzo 1913 toccò a Giorgio I re di Grecia a Salonicco. L’autore del gesto fu arrestato e torturato ma si suicidò lanciandosi – come fu detto – da una finestra. Nel 1921 l’attentato dinamitardo al teatro Diana di Milano per colpire, pare, un questore che invece restò incolume ed arrestò l’anarchico Antonio Pietropaolo e una decina di sospettati, alcuni dei quali finirono all’ergastolo. Anche l’ultimo tiranno d’Italia subì diversi attentati, alcuni veri, altri fasulli. Quello di piazza Loreto a Milano, il 29 aprile 1945, gli fu fatale. Chiudiamo questa lunga serie di violenze contro i tiranni con l’attentato a Luìs Carrero Blanco, il capo di governo di Franco, colui che doveva succedergli e che fu fermato dagli autonomisti baschi nel 1973.
La forza dell’azione Lo sosteneva Carlo Pisacane: la politica, la propaganda, i libri servono a poco; per dare forza ad un’idea occorre l’azione. Convinzione che volle dimostrare vera con la famosa spedizione di Sapri del 1857 e che in seguito fu alla base di molti attentati anarchici. Nel 1877 l’esempio di Pisacane fu seguito dalla banda del Matese capeggiata da Cafiero, Malatesta e Ceccarelli che andavano per i Comuni di quella regione assaltando gli uffici municipali per distruggere la “carta bollata”: i registri catastali, gli schedari delle tasse, gli atti delle ipoteche; volevano far capire che si potevano abolire tutti i cosiddetti “i diritti dello Stato e della proprietà privata”. La loro azione dimostrativa durò cinque giorni poi furono bloccati dai bersaglieri, catturati, processati e condannati; ma a pene poco pesanti. L’idea di Pisacane fu accolta e fatta propria nel 1881 dal congresso internazionale anarchico di Londra che annunciò di voler adottare “la strategia della propaganda col fatto”. Anche il duce del fascismo a suo modo utilizzò la “propaganda col fatto”: accettando e proteggendo l’azione dei sansepolcristi contro le sedi socialiste e sindacali, contro i loro giornali, contro i loro rappresentanti, a cominciare da Giacomo Matteotti che di quel tipo di propaganda fu un’illustre vittima. Poi cambiarono i tempi, subimmo l’amara lezione della guerra e, forse, maturarono anche le persone e l’anarchismo si affievolì. Quello ufficiale fu rappresentato dalla Federazione anarchica italiana (Fai) che pur rinunciando a metodi violenti inscenò spesso atti dimostrativi. Alcune frange però continuarono la scia del sangue: pare che l’uccisione di Carlo Falvella, militante del Fuan, accoltellato nel 1972 dall’anarchico Giovanni Marini, sia stato uno degli ultimi attentati vecchio stampo prima degli anni di piombo. Dopo di lui nel 1973 l’anarco-individualista Gianfranco Bertoli andò a lanciare bombe davanti alla questura centrale di Milano: una quarantina i feriti, quattro i morti (tutte persone che erano lì per caso). La sua azione –sostenne – voleva essere una protesta contro l’allora ministro Mariano Rumor che aveva inaugurato un busto commemorativo del commissario di Ps Luigi Calabresi, assassinato l’anno precedente da un gruppo di Lotta continua perché ritenuto responsabile della morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli, il quale era stato arrestato perché ritenuto coinvolto nella strage di piazza Fontana del 1969. È noto che, durante l’interrogatorio, il Pinelli era (o sarebbe?) caduto da una finestra del quarto piano della questura. Sulla scena dell’Italia degli scontenti è poi arrivata una Fai insurrezionalista che non ripudia l’azione armata o gesti dimostrativi più o meno violenti. Nel 2003 una campagna dinamitarda contro Istituzioni dell’Ue allo scopo di colpire “gli apparati di controllo e repressione del nuovo ordine europeo” attraverso l’invio di pacchi-bomba. Nello stesso anno un attentato contro Romano Prodi, presidente della Commissione europea la quale aveva introdotto “nuove pratiche di sfruttamento e di dominio”. Nel dicembre 2008 fu collocato un chilo d’esplosivo ai piedi di una guglia del duomo di Milano che però non esplose perché un operaio la notò e gli artificieri la disinnescarono. Nel dicembre dell’anno dopo ancora una bomba, dentro l’università Bocconi, per chiedere la chiusura dei centri di identificazione ed espulsione. Nel 2010 fallito attentato contro la Lega Nord, una lettera con proiettili al presidente del consiglio Berlusconi e lettere esplosive alle ambasciate di Svizzera, Cile e Grecia. L’anno dopo pacco bomba ad Equitalia (Roma) per protestare contro le misure economiche imposte dal governo Monti che provoca due feriti. Nel maggio 2012 la protesta più grave: la gambizzazione di Roberto Adinolfi, Ad dell’Ansaldo nucleare di Genova, per aver favorito il rientro del nucleare in Italia. Sempre a Genova, ma dieci anni prima, era entrato in azione il gruppo di Solidarietà internazionale spalleggiato da gruppi anarchici, nostrani e non, durante il vertice del G8: riuscirono a devastare una vasta zona della città e a creare le condizioni perché ci scappasse una vittima.
Un attentato avrebbe fermato Hitler? È stato calcolato che tra il 1875 e il 2004 si sono verificati circa 300 casi di morte al tiranno: più della metà affrontati a mano armata, il 45 per cento con bombe. I successi sono stati favorevoli agli attentatori solo in un caso su cinque. Ne hanno discusso recentemente su La Lettura tre studiosi di cose politiche chiedendosi se un attentato che avesse tolto di mezzo Hitler sarebbe riuscito a fermare la guerra e a soffocare il nazismo. “Ogni tiranno ha dietro di sé una base più o meno estesa che domina sul resto della comunità – ha sostenuto Luciano Canfora – quindi il problema non è tanto eliminare fisicamente il despota quanto sconfiggere politicamente il sistema di potere che lo sorregge”. Ed ha ricordato il caso l’attentato ad Umberto I: “Non fu l’uccisione del sovrano da parte
di un militante anarchico a chiudere la reazione italiana di fine ‘800 e ad aprire la strada al liberale Giolitti ma un complesso di movimenti politici e sociali che aveva trovato nella rivolta di Milano del 1898, repressa nel sangue, la sua maggior espressione”. Luigi Curini ha detto che oggi si assegna troppo facilmente l’epiteto di tiranno a qualcuno; anche lui però è d’accordo: “Non è la violenza fisica ma il discredito politico l’arma più efficace contro la tirannia”. L’assassinio di un leader liberamente eletto di solito non modifica la natura di un regime, mentre l’omicidio di un dittatore aumenta, da una parte il livello di conflittualità nel Paese interessato e dall’altro ne incentiva l’evoluzione in senso favorevole alla libertà. Secondo uno studio recente sembra che una dittatura il cui leader viene ucciso ha il 13 per cento di possibilità in più di diventare una democrazia nell’anno successivo all’attentato, quindi “se gli omicidi non hanno mai cambiato la storia del mondo, come sosteneva il primo ministro britannico Benjamin Disraeli, tuttavia un attentato può modificare la traiettoria di uno Stato”. Non bisogna concentrarsi sull’antropologia del tiranno o sulla personalità del singolo dittatore ma piuttosto sul sistema che lo esprime” sostiene anche Luigi Manconi. Nel caso di Carrero Blanco, ad esempio, si è trattato di un tirannicidio che, se non altro, ha prodotto l’effetto di accelerare la transizione della Spagna verso la democrazia. Tuttavia non è facile vedere nel mondo una situazione in cui il tirannicidio possa rivelarsi determinante. È comunque necessario prestare più attenzione alle derive liberticide che si manifestano in alcuni Paesi. Gli esempi citati sono l’Ungheria di Orbàn, la Turchia di Erdogan e l’Egitto di Al Sisi, solo per citare casi a noi più prossimi. È invece da bandire la pretesa di poter “esportare la democrazia”; già Robespierre lo diceva, come ha ricordato Canfora: “I popoli non amano i missionari armati!”. “L’uso delle armi non è efficace contro le dittature – è anche il parere di Curini – “se si vuole espandere la democrazia nel mondo bisogna ricorrere a strumenti politici: sostegno alle opposizioni, aiuti economici condizionati, tentativi di sviluppare la società civile là dove è debole e oppressa”. E questi sono strumenti ben più costosi di un drone armato che vola sulla testa del dittatore. A conclusione Luigi Manconi ha citato il caso dell’omicidio Regeni al Cairo dal quale “emerge una lezione terribile: l’incapacità delle democrazie di evitare che nei rapporti internazionali la tutela dei diritti umani finisca all’ultimo posto rispetto ad esigenze di altra natura”. Il che ci porta a concludere che la tirannia è un morbo tutt’altro che facile da estirpare. Per fortuna sembra che i casi conclamati di questo tipo di infezione sociale non siano frequenti in Europa. Nel resto del mondo se ne contano invece numerosi.